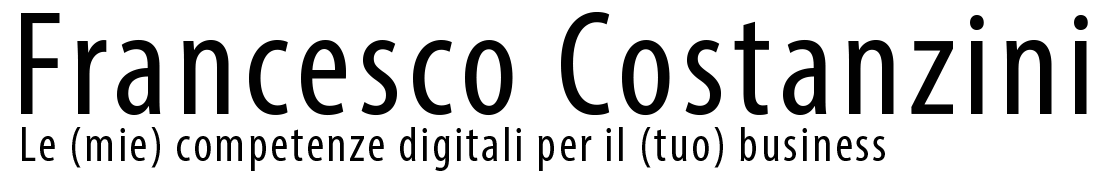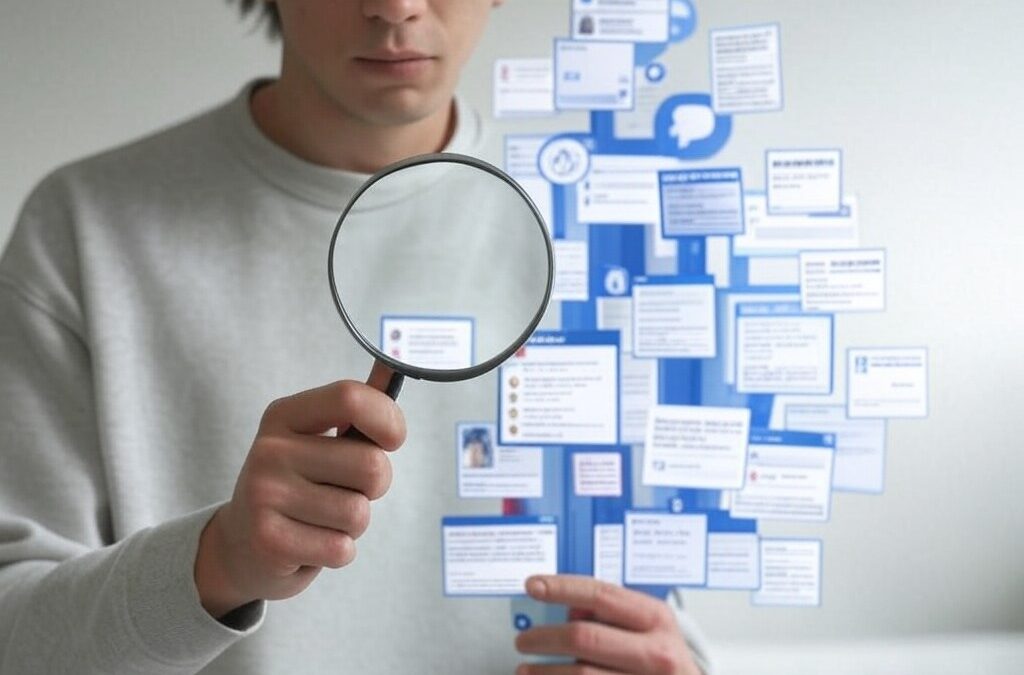Il poeta e critico letterario T.S. Eliot, in The Rock (1934), scrisse: “Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information?” (Dov’è la saggezza che abbiamo perso nella conoscenza? Dov’è la conoscenza che abbiamo perso nell’informazione?).
Questa citazione sottolinea come l’eccesso di informazioni possa ostacolare l’acquisizione di vera conoscenza e saggezza, descrivendo perfettamente il nostro tempo.
Che cos’è l’infodemia
Il termine infodemia fu utilizzato per la prima volta da David J. Rothkopf in un articolo del 2003 intitolato “When the Buzz Bites Back“. Rothkopf lo definì come “un’epidemia di informazioni che si diffonde rapidamente attraverso le reti di comunicazione moderne, rendendo difficile distinguere i fatti dalla finzione e portando spesso a decisioni sbagliate.” Successivamente, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha adottato il termine durante la pandemia di COVID-19, ampliandone il significato per descrivere l’abbondanza eccessiva di informazioni, alcune accurate ma molte fuorvianti, che rende difficile per le persone trovare fonti affidabili e orientarsi.
Questo periodo come riportato nello studio “Infodemics: A new challenge for public health” di Briand, Sylvie C. et al. (Cell, Volume 184, Issue 25, 6010 – 6014) vide un’inondazione di disinformazione che non solo confuse il pubblico, ma ne influenzò anche il comportamento, creando un terreno fertile per false credenze. Tra queste, l’idea che il 5G potesse propagare il virus portò a paure ingiustificate e a reazioni esagerate.
Per ovvi motivi, l’infodemia non è solo un fenomeno che resta legato al COVID-19: essa riflette problemi più ampi, come l’espansione incontrollata dei social media e la difficoltà di distinguere tra notizie affidabili e contenuti manipolati in un contesto di accesso immediato alle informazioni.
Uno studio di Caliandro et al. (2020) ha analizzato oltre 7 milioni di tweet italiani per comprendere l’entità della disinformazione durante la pandemia di COVID-19. I risultati mostrarono che solo l’1,44% dei tweet conteneva fake news. Tuttavia, queste notizie false tendevano a circolare in periodi specifici e in comunità chiuse, spesso caratterizzate da narrative politiche polarizzanti. Lo studio sottolinea come, pur essendo quantitativamente limitate, queste dinamiche possano influenzare significativamente il dibattito pubblico, amplificando stereotipi e divisioni sociali. Questo dimostra come l’infodemia, pur essendo quantitativamente limitata, possa avere un impatto qualitativo significativo.
L’impatto dell’infodemia sulla nostra vita
Le conseguenze dell’infodemia sono molteplici e spesso interconnesse. Come evidenziato dall’Accademia della Crusca, l’eccesso di informazioni, spesso contraddittorie, provoca confusione e rende difficile per le persone distinguere tra fonti affidabili e contenuti inaffidabili, alimentando un clima di sfiducia generalizzata. Questa situazione porta inoltre ad un aumento significativo dello stress e dell’ansia, poiché l’esposizione continua a notizie sensazionalistiche tende a generare uno stato di allarme costante.
Un altro impatto rilevante riguarda i comportamenti delle persone. Le informazioni false o fuorvianti, quando non adeguatamente contrastate, possono condurre a decisioni rischiose, come l’evitare vaccinazioni o trattamenti medici validati. L’infodemia non si limita a influenzare il livello individuale ma amplifica problemi sociali e culturali preesistenti.
Aumenta, ad esempio, le disuguaglianze nell’accesso all’informazione e contribuisce a minare la fiducia nelle istituzioni pubbliche, aggravando le difficoltà nella gestione delle crisi sanitarie.
Questo fenomeno, osservato in vari contesti, dimostra come una gestione inefficace delle informazioni possa aggravare situazioni già critiche e ostacolare interventi di salute pubblica efficaci.
Strategie pratiche per affrontare l’infodemia
Combattere l’infodemia richiede approcci pratici e integrati. Un esempio recente è il toolkit pubblicato dall’OMS all’inizio del 2024, intitolato “Managing False Information in Health Emergencies: An Operational Toolkit“. Questo toolkit propone un processo operativo in cinque fasi per rilevare e gestire le informazioni false in situazioni di emergenza sanitaria.
Le fasi includono: rilevamento dei segnali, verifica dei segnali, valutazione dei rischi, progettazione della risposta e attuazione e monitoraggio della risposta.
Ogni fase è accompagnata da strumenti pratici, casi studio e linee guida operative per affrontare efficacemente le sfide poste dall’infodemia.
Ad esempio, il toolkit descrive dettagliatamente il processo di “rilevamento dei segnali”, che include il monitoraggio dell’ecosistema informativo attraverso l’uso di strumenti digitali e metodi offline per identificare segnali di disinformazione. La “verifica dei segnali” si concentra sulla convalida delle informazioni, valutando la credibilità delle fonti e il contesto dei contenuti. Nella “valutazione dei rischi”, si analizzano l’impatto potenziale sulla salute pubblica e la portata della disinformazione per definire priorità d’intervento. La “progettazione della risposta” guida nella creazione di messaggi efficaci e strategie di comunicazione, mentre la fase di “attuazione e monitoraggio” enfatizza l’importanza del feedback continuo per migliorare le azioni. Il toolkit non solo fornisce esempi concreti e check-list per ciascuna fase, ma offre anche risorse per formare le comunità e rafforzare la capacità delle istituzioni di gestire le crisi informative.
Questo approccio si integra con il modello 4i FACT (Framework for Advancing Communication and Trust), proposto in precedenza da Sundelson et al. (2023). Lo studio analizza oltre 350 strumenti volti a combattere la disinformazione e propone un approccio integrato basato su quattro livelli: informazione, individuo, comunità e istituzioni.
Gli autori sottolineano l’importanza di amplificare contenuti affidabili, migliorare la literacy informativa, coinvolgere le comunità e regolamentare i social media per affrontare in modo strutturato le complessità dell’infodemia.
Questo modello identifica quattro livelli di intervento:
- Informazione:
- Amplificare contenuti affidabili e verificati.
- Riempire i vuoti informativi tramite strumenti come chatbot e collaborazioni con i motori di ricerca.
- Debunking di informazioni false, monitorando le conversazioni online.
- Individuo:
- Promuovere la conoscenza, la consapevolezza informativa e il pensiero critico.
- Prebunking: educare le persone su tecniche comuni di disinformazione per rafforzarne la resistenza.
- Comunità:
- Coinvolgere messaggeri locali per creare fiducia e diffondere informazioni corrette.
- Iniziative come il programma SQUAD™ in cui negli Stati Uniti vengono formati leader comunitari per contrastare le false credenze.
- Istituzioni:
- Regolamentare i social media per ridurre la visibilità delle fake news.
- Fornire strumenti e risorse per giornalisti e fact-checker, figure professionali dedicate alla verifica dell’accuratezza delle notizie e alla smentita di contenuti falsi o fuorvianti, migliorando la qualità dell’informazione pubblica.
L’infodemia è sicuramente un fenomeno complesso, ma affrontabile. Ognuno di noi ha la responsabilità di contribuire al miglioramento dell’ecosistema informativo, non solo per proteggere se stessi, ma anche per il bene della collettività. Essere consapevoli e adottare un approccio critico verso le informazioni che consumiamo è una goccia nel mare, ma è proprio dall’insieme di queste gocce che nasce un cambiamento. Con approcci integrati e strategie mirate possiamo ridurre l’impatto delle informazioni false, promuovendo una cultura della verifica e della fiducia, essenziali per affrontare le sfide del nostro tempo.
Per approfondire queste tematiche e ricevere riflessioni sempre aggiornate, iscriviti al mio canale Telegram e seguimi su LinkedIn.